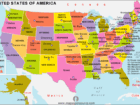Storia delle Brigate Rosse a Genova
Sergio Luzzatto ricostruisce in un saggio la storia di una delle colonne simbolo della lotta armata.
L’articolo-intervista di Massimo Pisa è pubblicato nel “Venerdì di Repubblica” del 22 settembre 2023, alle pp. 47-49.
La guerra e la città ricurva. Genova con le sue fabbriche di Stato a far da corona al porto e all’aristocrazia universitaria di Palazzo Balbi. Popolata nei suoi caruggi e nei palazzoni della speculazione da una periferia umana che innerverà la colonna delle Brigate Rosse. “Dolore e furore”, in uscita per Einaudi, ultima fatica di Sergio Luzzatto –genovese di nascita e ordinario di Storia moderna europea a UConn- è un affresco documentatissimo dove ai terroristi come Riccardo Dura e alle vittime come Guido Rossa si somma lo sfondo unico della Superba.
Una storia, professor Luzzatto, e insieme una geografia locale della lotta armata.
La storia ha un prisma per centro ed è la città di Genova. Del resto, le BR erano strutturate in colonne che avevano bisogno di radicarsi sul territorio e una storia del terrorismo non può che essere una storia del rapporto tra territorio e politica. Studiare la colonna brigatista, dandola per fatta, avrebbe mancato l’obiettivo. Mi sono domandato chi ne faceva parte, ho fatto quella che oggi si chiama una gallery dei personaggi, e mi sono chiesto da dove venivano.
Risalendo alla formazione dei brigatisti nel Sessantotto genovese.
Non si può capire la storia degli anni Settanta senza partire dai Sessanta, da quei movimenti e migrazioni. Quella del terrorismo, che si esercita soprattutto al Nord, è una storia di capi che vengono dal Sud, immigrati che maturano in un contesto locale particolarmente ricco. Genova è un laboratorio straordinario non solo per la vitalità culturale della classe operaia o per il ruolo delle due grandi chiese, il Pci e l’arcivescovado del cardinale Siri. E’ la città di Fabrizio De André, di don Gallo, di Lisetta Carmi, di bassifondi e travestiti, di via del Campo. Un mondo estraneo alla fabbrica che convive, così come il porto e i camalli, con l’industria di Stato in una dimensione dinamica e problematica.
La Genova operaia resterà in massima parte impermeabile alla lotta armata…
Non si capisce l’isolamento della colonna genovese, efficiente e spietata ma senza un vero radicamento sul territorio, se non si parte da qui. L’operaio di fabbrica comunista, pur affascinato dalla rivoluzione, non si riconosce nell’avanguardia delle Br e continua a sognare una via democratica. Centrale è la figura di Guido Rossa, sindacalista e militante che fa l’informatore per il Pci a garanzia delle istituzioni, percepito però come spia dai suoi assassini perché non obbedisce alla regola di ferro della solidarietà operaia. Ebbene, nelle loro lettere private negli anni ’69-’70, i futuri nemici condividevano un comune sentire rivoluzionario. Da questa realtà ricca di ingredienti si staccherà una minoranza e si incisterà in questa specie di guerra privata che poi diventa il terrorismo. Guido Rossa è l’immagine di questa tensione e di questa tragedia.
Il “dolore” del titolo, tratto da una corrispondenza tra lei e Rossana Rossanda, lo ritroviamo nelle tragedie personali di tanti personaggi del libro. Tanto da pensare che, più che da Lenin, il loro furore rivoluzionario derivasse da Freud.
Mi riconosco molto in un’idea di una ferita originaria. Prendiamo Rocco Micaletto, finora trascurato dagli storici, che delle colonne genovese e torinese è fondatore e diventerà il braccio destro di Mario Moretti. E’ un figlio della terra del rimorso, del Salento di Ernesto De Martino, dei tarantolati, del pianto rituale. Porta in sé la doppia ferita dei figli del Sud, spaesato e discriminato nel triangolo industriale, vittima di soprusi nell’indotto Fiat. Le Brigate Rosse sono più o meno questo: dei feriti della modernizzazione che poi feriscono e uccidono a loro volta.
Il simbolo di questa storia è Riccardo Dura, il “terrorista perfetto”, il ragazzino estraniato nella nave-lager Garaventa che sarà killer di Rossa e poi ucciso in via Fracchia.
Dura è veramente un outcast, il perdente radicale disegnato da Enzensberger, una figura di sradicato che non ha una storia di acculturazione teorica. E’ un personaggio alla Conrad: uno schiavo moderno che a un certo punto dice basta. E cospargerà dolore, che ho inteso con una doppia semantica. Peraltro anche il furore è doppio: quello delle Br e quello della repressione. Il disegno dello Stato, di quelli che chiamo “i due gemelli piemontesi”, cioè Carlo Alberto Dalla Chiesa e il magistrato Adolfo Beria d’Argentine, fu lucido. Con il generale che, da uomo delle istituzioni, si è assunto la responsabilità storica di fare il lavoro sporco.
La sconfitta delle Br cominciò proprio a Genova…
 Sì, qui capiscono di avere perso perché non penetrano la classe operaia: il sacrificio di Guido Rossa è la dimostrazione più patente. Qui rinunciano alla dimensione dell’egemonia politica per metterla disperatamente in termini di rapporti di forza. Però è militare anche la repressione dello Stato. L’Asinara, il sistema delle supercarceri, l’irruzione con i quattro morti di via Fracchia con un messaggio chiaro: la volontà di non fare più prigionieri. E contestuali sono le leggi sui pentiti. La partita disegnata da Dalla Chiesa e Beria d’Argentine è su due livelli e più di tutti lo comprende Giovanni Senzani, genovese d’adozione, sociologo e criminologo che si era formato tra gli outcast di Berkeley, che da capo delle Br porterà questa idea: se anche non conquistiamo la classe operaia, abbiamo una massa di impoveriti e non tutelati che possono costituire la vera forza collettiva per la rivoluzione.
Sì, qui capiscono di avere perso perché non penetrano la classe operaia: il sacrificio di Guido Rossa è la dimostrazione più patente. Qui rinunciano alla dimensione dell’egemonia politica per metterla disperatamente in termini di rapporti di forza. Però è militare anche la repressione dello Stato. L’Asinara, il sistema delle supercarceri, l’irruzione con i quattro morti di via Fracchia con un messaggio chiaro: la volontà di non fare più prigionieri. E contestuali sono le leggi sui pentiti. La partita disegnata da Dalla Chiesa e Beria d’Argentine è su due livelli e più di tutti lo comprende Giovanni Senzani, genovese d’adozione, sociologo e criminologo che si era formato tra gli outcast di Berkeley, che da capo delle Br porterà questa idea: se anche non conquistiamo la classe operaia, abbiamo una massa di impoveriti e non tutelati che possono costituire la vera forza collettiva per la rivoluzione.
Senzani, lo spietato sicario di Roberto Peci, ed Enrico Fenzi, lo studioso di Petrarca: i due cognati rossi sono un altro unicum genovese.
Fenzi abita due mondi: quello dell’università e del sapere, e l’altro, quello della rivolta e dell’emarginazione. Ci riporta in via Balbi, luogo del grande incontro tra operai e studenti, mediato dai professori padroni di casa. Era esattamente il mondo detestato dal generale Dalla Chiesa, in cui una minorité agissant di studenti e capetti, manipolando una generazione intera di giovani reclute, ha cercato di vendicare la rivoluzione tradita dalla generazione dei padri. Fenzi e Senzani sono gli unici due veri intellettuali che abbiano avuto ruoli di responsabilità nelle Br. Ed è Fenzi che si presta, fino alla gigioneria, ad incarnare la figura dell’allievo di Rocco Micaletto, l’intellettuale che si spoglia dei propri panni curiali per mettersi al servizio dello spirito della storia.
Restano, oltre al dolore per vittime e caduti, il senso di una sconfitta collettiva e di un’occasione perduta.
Questa è una storia di decadenza strutturale. Di una città e di un Paese. I risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti. La classe operaia non esiste più in quella forma. Il patto della Costituzione antifascista, di fondare la Repubblica sul lavoro e sui lavoratori, fatichiamo oggi a riconoscerlo. Nel caso di Genova è una storia precoce di fine, e il dramma delle Brigate Rosse è di essere stati dei late comers in una città deindustrializzata e trasformata, che vive la perdita di identità e centralità operaia. Poteva finire diversamente? Ancora oggi non sappiamo in misura piena cosa successe nell’Italia del 1974, quella del pericolo di golpe così fortemente percepito che spinse i militanti più motivati verso scelte radicali. Non dipese solo dai brigatisti, ed è qua che la strategia della tensione torna protagonista: le forze, legali o illegali, che spingevano esattamente verso una radicalizzazione dello scontro.
Massimo Pisa Sergio Luzzatto