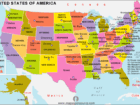L’equivoco Don Milani
Adolfo Scotto di Luzio riesamina la “Lettera a una professoressa” smascherando la lettura fatta dal ’68.
Nel supplemento domenicale del “Il Sole 24 Ore” dell’11 giugno 2023, a pag. VIII, è pubblicato l’articolo di Gabriele Pedullà.
Nella grande famiglia delle discipline umanistiche la storia della pedagogia occupa oggi una posizione un poco appartata, persino marginale. E’ un chiaro errore di percezione, se non altro perché sul tema dell’educazione si sono scontrati tutti i grandi disegni politici novecenteschi. Liberali, socialisti, cattolici, fascisti, comunisti: con tonalità diverse (ma anche con scambi e filiazioni inaspettate), a partire dal Risorgimento non c’è movimento intellettuale che in Italia non si sia posto il problema dell’uomo nuovo. E questo uomo nuovo, proprio in quanto ancora tutto da costruire, non poteva che essere oggetto di speciali cure a cominciare dagli anni della formazione se –come amava dire William Wordsworth- “il bambino è il padre dell’adulto”.
Probabilmente nessuno quanto Adolfo Scotto di Luzio si è impegnato negli ultimi lustri per ridare centralità alla questione, anzitutto ricordando ai lettori che per più di un secolo la migliore teoria politica italiana si è confrontata direttamente o indirettamente con il tema dell’educazione: cosa insegnare, come riuscirci e a quale scopo. E lo ha fatto alternando solide ricostruzioni storiche (sull’editoria scolastica fascista, sul liceo classico, sugli anni ’80 del Novecento come momento di svolta) a interventi più militanti, per esempio contro la famigerata scuola 2.0 di Matteo Renzi.
Nel centenario della nascita del prete di Barbiana, questo saggio, “L’equivoco Don Milani” (Einaudi, pp. 160, € 12), si colloca in qualche modo a metà strada tra questi due filoni di intervento. Da un lato, infatti, questo è un libro agile, calato nell’attualità e animato da una chiara vis polemica. Dall’altro, però, Scotto di Luzio punta a una radicale storicizzazione dell’esperienza pastorale ed educativa di don Milani che finalmente lo liberi dai troppi usi strumentali.
Più dell’anno della nascita, a contare nella sua fortuna successiva sembra essere stato quello della sua morte: il 1967, a un mese dalla pubblicazione del suo manifesto contro la scuola classista della borghesia, la celebre “Lettera a una professoressa”, che il Sessantotto avrebbe trasformato in un classico della contestazione. Come l’autore suggerisce, è la prematura scomparsa di don Milani ad aver reso possibile le più diverse appropriazioni del suo pensiero, come mai sarebbe accaduto se l’autore avesse accompagnato per qualche anno ancora la sua opera. Contro il santino che gli ammiratori hanno cucito addosso a don Milani, Scotto di Luzio ha dunque buon gioco a dimostrare per esempio quanta religiosità controriformista spiri nelle pagine di don Milani, che solo per un colossale malinteso è potuto diventare un punto di riferimento per il movimento studentesco prima e per un Partito Comunista in cerca di identità poi.
Don MIlani è chiaramente un avversario intellettuale assai più profondo e affascinante di Matteo Renzi, e Scotto di Luzio non esita a mostrare l’estrema complessità culturale e umana della sua figura. Centro pulsante del suo saggio è però anzitutto la difesa della scuola come luogo dove si attua il trasferimento, vale a dire il passaggio dalla natura alla libertà in nome di una infedeltà all’origine (sociale). Perché, appunto, un tempo proprio “a questo serviva la scuola: a liberarsi del passato” (si noti lo sconsolato pessimismo implicito nell’imperfetto).
Scotto di Luzio apprezza la “Lettera a una professoressa” per la nettezza con cui don Milani denuncia il peso dei condizionamenti sociali nella riuscita dei ragazzi e “come strumento correttivo nella relazione tra il maestro e l’allievo”. Allo stesso tempo ne rifiuta tuttavia l’assunto centrale, spesso sottaciuto dai suoi apologeti: l’idea cioè che i poveri non vadano strappati dalla loro povertà, perché è questa la loro virtù maggiore, quella che li predispone ad accogliere il messaggio evangelico. E che dunque l’insegnamento debba proporsi di costruire sì la loro autostima (al contrario di una scuola tradizionale che tendeva a distruggerla), ma senza aprirli a un’alta cultura che per don Milani puzza sempre di borghesia e di corruzione. I poveri non devono insomma cambiare, ma esibire orgogliosamente la propria alterità e separatezza: a questo serve la scuola per don Milani –non troppo diversamente da come madre Teresa di Calcutta affermava di non voler combattere la povertà, ma aiutare i poveri a fare di essa un buon uso (cristianamente). Nel Paese di Carlo Levi e Pier Paolo Pasolini, dove la nostalgia della presunta superiore moralità dei pellagrosi si è spesso affacciata negli scritti degli arcadi novecenteschi, simili posizioni non sono state rare. Scotto di Luzio però nota giustamente soprattutto il paradosso di quanti, soprattutto a sinistra, si richiamano a don Milani quando ricordano il principio inscritto nell’articolo 34 della Costituzione: “I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Nulla di tutto questo ha mai auspicato infatti il prete di Barbiana.
La scuola repubblicana è stata (o ha cercato di essere) il luogo del superamento delle differenze: uno spazio di costruzione del cittadino e di selezione di una élite pubblica non fondata sulle condizioni familiari pregresse. Ed è questa la scuola che Scotto di Luzio, assai coraggiosamente, difende oggi nei suoi libri: contro tutti i nemici dell’emancipazione. Dunque contro chi, come don Milani, in essa vedeva solo il traviamento della purezza creaturale degli indigenti. Ma anche contro chi, come gli odierni teorici della scuola-impresa, crede sia arrivato il momento di mettere il processo educativo interamente al servizio del mercato del lavoro, archiviando per sempre i sogni otto novecenteschi di pedagogia integrale per le masse.
Gabriele Pedullà