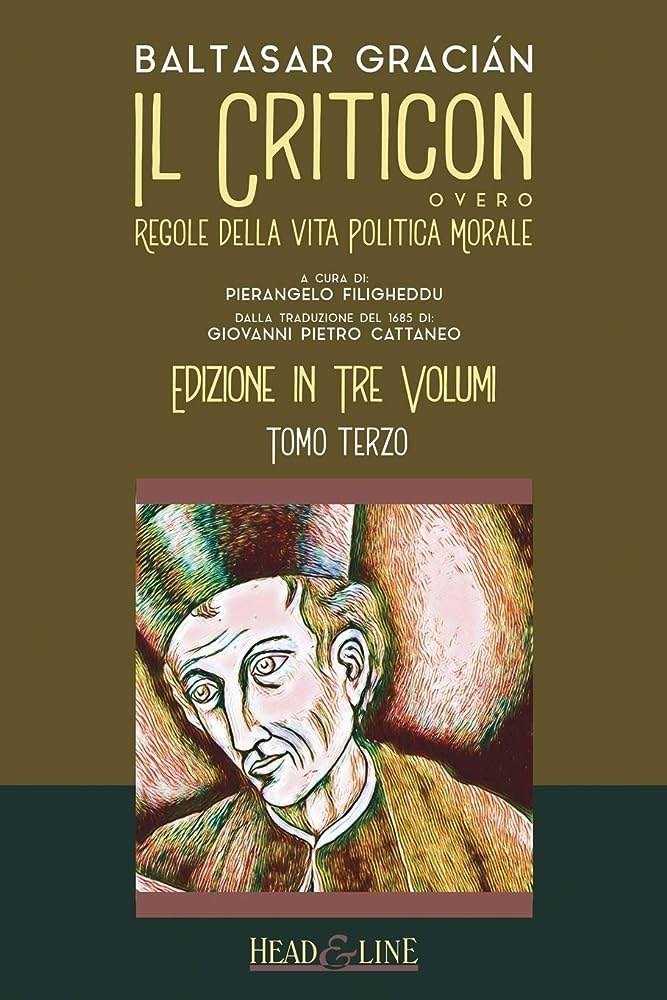Baltasar Graciàn, il gesuita ribelle
Escono in nuova traduzione gli aforismi del grande scrittore barocco spagnolo. Osteggiato dalle gerarchie, analizzò un’epoca in crisi con lucidità tagliente e “scorretta”, finendo al confino.
Ne “il Venerdì di Repubblica” dell’11 dicembre 2020, alle pp. 104-107, è pubblicato un articolo di Marco Cicala, nel quale si commenta la ripubblicazione, per Adelphi, del più importante saggio dello scrittore.
Quasi negli stessi anni dell’uscita alle stampe dell’opera di Gracian (1647), in Italia veniva pubblicato il trattato di Torquato Accetto, “Della dissimulazione onesta” (1641), leggendo il quale riusciamo a scendere in una piega profonda ed oscura della spiritualità secentesca. Infatti, solo una condizione di estrema costrizione spirituale e di precarietà materiale poteva spingere un intellettuale a scrivere un testo nel quale si suggerisce apertamente di praticare la “dissimulazione”, cioè la capacità di nascondere ciò che si è. La vita terrena concepita come un doloroso pellegrinaggio, che l’uomo compie tra infiniti pericoli dai quali deve sapersi guardare, se aspira a godere di quella felicità che solo la morte concede. La verità, in certe condizioni, la si può salvaguardare solo se la si nasconde. E’ la dissociazione più acuta che si possa immaginare tra prassi reale e convincimento religioso.
Qualche decennio prima un altro religioso italiano, il frate servita veneziano Paolo Sarpi, aveva scritto con lucida drammatica amarezza: “Se vivi in Italia una maschera sei costretto a portare”.
Gennaro Cucciniello
In un’estate infuocata di qualche anno fa andai a Belmonte, il villaggio dove nel 1601 era nato il “gesuita ribelle” Baltasar Graciàn y Morales. E’ un borgo agricolo di duecento abitanti, ma ne dimostra meno. Parcheggiati nelle strade deserte, incontri più trattori che automobili. Fra grappoli di casupole intonacate alla buona e sovrastate dalla minacciosa mole di una chiesa, anche l’edificio nel quale venne al mondo l’illustre paesano avrebbe bisogno di una rinfrescata. Sulla facciata stanno appiccicate tre vecchie targhe commemorative che l’incuria ha reso pressoché illeggibili. Fortunatamente, negli ultimi decenni, la posterità –non solo spagnola- ha riservato a Graciàn un trattamento più adeguato alla statura del suo vertiginoso ingegno. Dopo aver ripreso colorito nella temperie culturale del “postmoderno” e della riscoperta un po’ modaiola del “barocco”, la lettura di Graciàn sembra oggi rientrata nell’alveo di studi specialistici che al geniale poligrafo aragonese hanno restituito il meritato valore di un classico, ma senza che il grande pubblico se ne sia accorto granché. Motivo in più per plaudire alla ripubblicazione adelphiana di “Oracolo portatile ovvero l’arte della prudenza”, sintesi del Graciàn pensiero che ora torna in una nuova traduzione firmata da Giulia Poggi e accompagnata da un poderoso saggio del compianto storico francese Marc Fumaroli.
Dato alle stampe nel 1647, l’Oràculo ripescava, volgendole in aforismi, frasi estratte da testi precedenti dell’autore (i trattati “El Héroe, El Politico, El Discreto). Ma quel riciclaggio costituisce solo un quarto del libro. Il resto delle trecento “massime” contenute nel manual sono nuove. Rileggendole, la prima domanda che sorge spontanea è: ma che diamine è successo alla prudenza? Antica virtù pagana poi annoverata dalla Chiesa nel ristrettissimo club di quelle “cardinali”, sembra ormai scaduta a disvalore, sinonimo di infingardaggine, se non di codardia; vilipesa dal culto giovanilistico della “vita spericolata” come dalla –congiunta- religione imprenditoriale del rischio, della scommessa, dell’azzardo sparviero. E tuttavia in Graciàn l’idea di prudencia ha poco a che vedere con quella classica o religiosa. E’ più machiavellica, politica, strategica. Insomma eminentemente “moderna”. Tanto di politica quanto di strategia Graciàn se ne intendeva. Perché aveva trascorso anni nelle Corti di Spagna e partecipato –da cappellano, ma qualcuno sostiene perfino da combattente- alle guerre territoriali che laceravano il Paese. Se la Compagnia di Gesù fu concepita dal fondatore Ignazio di Loyola come una “milizia”, Baltasar Graciàn ne fu un soldato. Ma interpretando la missione in ottemperanza all’adagio secondo cui “il migliore dei soldati è quello che sa quando disobbedire”. “Milizia è la vita dell’uomo, contro la malizia dell’uomo” recita la massima n. 13 dell’Oracolo. Però il malizioso Graciàn militerà contro la malizia lasciandosene contaminare come lo sbirro dal furfante.
Era nato da una famiglia del micro-notabilato di provincia, da una stirpe di “cristiani vecchi”, ossia non mescolata a sangue ebraico o musulmano. A 17 anni studia dai gesuiti di Saragozza, a 34 prende i quattro voti della Compagnia. Spostandosi in mezza Spagna, farà carriera come cattedratico e assistente spirituale di alti dignitari della Corona. La svolta avviene però nel 1636 a Huesca, dove Baltasar frequenta il cenacolo del molto illuminato, per la Spagna dell’epoca, Vincencio Juan de Lastanosa. Mecenate, erudito, collezionista, don Vincencio custodisce nella grande dimora con giardino antichità, strumenti astronomici, animali esotici, carte geografiche, opere d’arte e soprattutto una smisurata biblioteca umanistica di cui il professor Graciàn diverrà assiduo frequentatore emancipando le proprie letture dall’orbita esegetica, dottrinale e teologica nella quale erano rimaste fino ad allora relegate. Da quel momento la sua vita si trasformerà in uno snervante braccio di ferro con la compagine gesuita.
Il duello si innesca un po’ per le faide, le rivalità interne alla Compagnia e un po’ perché Graciàn esce dal seminato: senza l’approvazione delle gerarchie e sotto falso nome, pubblica opere mondane di scienza politica e cortigiana, di estetica, e poi sul finire, “El Criticòn” (1651-1657), monumentale romanzo filosofico-satirico che con il “Don Chisciotte” è la più formidabile impresa letteraria della Spagna aurea, ma per l’autore sarà una pietra tombale. Nel 1657, dopo vent’anni di indisciplina, il gesuita eccentrico viene confinato dai superiori nello sperduto borgo pirenaico di Graus dove lo si metterà in condizione di non nuocere: “Bisogna tenerlo d’occhio, esaminare ogni tanto la sua camera e le sue carte, non consentirgli di tener chiuso nulla”. E qualora lo si dovesse recludere, “non gli si permetta di avere con sé carta, penna e calamaio”. Tempo pochi mesi, Baltasar morirà a Tarazona.
Gemma crepuscolare del Siglo de Oro e di una Spagna che la Francia ha disarcionato dal ruolo di potenza egemone nel grande gioco europeo, l’opera di Graciàn è un’acuminata riflessione su quella decadenza, ma anche su come sopravviverle. Perché le fasi di declino non solo durano più di qualsiasi apogeo, ma possono rivelarsi maggiormente istruttive circa i comportamenti dell’animale-uomo. L’Oracolo portatile è stato a lungo considerato un semplice prontuario ad uso del perfetto cortigiano, frutto tardivo della sontuosa trattatistica rinascimentale sull’arte di condursi in società. Ma, pur impregnati di quella tradizione, gli aforismi dell’Oràculo –non per niente ammirati da Schopenhauer, che li tradusse in tedesco, e da Nietzsche- sono molto di più. Oggi li potremmo definire un ricettario di biopolitica. Saggio è per Graciàn colui che governa se stesso –passioni, ambizioni, affetti, relazioni sociali- come uno Stato. Anche da qui l’importanza accordata al “segreto”, concetto e pratica centrali nel suo pensiero (“Non dobbiamo lasciar scorgere a tutti il nostro intimo. Il riserbo silenzioso è il sagrato del senno”) e nel coevo sviluppo dello Stato moderno: lo ricordava il critico Giovanni Macchia in un testo del 1989, facendoci volare con l’abituale maestria dal secolo di Mazarino a quello di James Bond.
In Graciàn “El secreto” è meno un contenuto che una forma. Non tanto qualcosa che uno sa quanto un modo di stare al mondo, di serpeggiare tra le sue insidie dissimulando, osservando, origliando, raccogliendo informazioni, nascondendosi e quando necessario manifestandosi, però col contagocce. Se nell’antica concezione degli arcana imperii (i segreti del comando), l’impenetrabilità era requisito del sovrano e fonte del suo carisma, in Graciàn diventa l’occhiuta autodisciplina del suddito. Principio speculativo che, innervato dagli accorgimenti della psicologia loyoliana, si fa strumento per esplorare la realtà con tecniche da spia. Per Graciàn la conoscenza è una specie di dossieraggio, ma allo stesso tempo l’omertà è un’arte da gestire con stile, delicatezza, eleganza. Qui una voragine separa il nostro gesuita dalla Modernità voyeuristica del gossip. Come pure dall’idea che l’autenticità consista nel dirsi tutto. In lui quella del vedo-non vedo è insieme un’estetica e un’etica. Il segreto, un buon vino da lasciar invecchiare nelle cantine di sé e da condividere con parsimonia (“i segreti profondi stanno in fondo perché esistono grandi spazi e insenature dove sprofondano le cose di valore. La riservatezza comporta una grande padronanza di sé e il vincersi in questo è il vero trionfo”).
Anche perché rivelarsi o ricevere rivelazioni altrui crea vincoli di dipendenza dal prossimo (“Ogni qualvolta ci apriamo con qualcuno paghiamo una tassa”; Chi ha comunicato i suoi segreti a un altro si è reso suo schiavo”), mentre l’ideale a cui tende Graciàn è quello di un individuo monadico, autosufficiente, autarchico, e di una civiltà che riposi sulle virtù del mutuo riserbo. Certo, l’uomo per il quale l’Oracolo dovrebbe funzionare da navigatore è un animale perennemente sulla difensiva, vive sul chi vive, e nell’ansia di controllo tresca con la paranoia. Però negli aforismi si avverte un pendolarismo continuo tra gli imperativi della prudenza, della riservatezza, dell’equilibrio, e l’esuberanza barocca come estro, ricerca del nuovo, gusto dell’inusitato. E’ d’altronde in aperto contrasto con i dettami gesuitici di sobrietà e chiarezza nella scrittura o nella predicazione che, in “L’acutezza e l’arte dell’ingegno” (1648), Baltasar elabora una teoria estetica dove primeggiano quelle nozioni di inventiva, artificio, sorpresa che troveranno applicazione letteraria nelle pirotecnie del Criticòn.
Jorge Luis Borges liquidava il “concettismo”, l’iperbolico stile di Graciàn come un “vano erbario di metafore e di arguzie”, un arido ammasso di “labirinti, giochi di parole, emblemi… Stratagemmi”. In bilico tra disinganno e illusionismo, l’arte dell’aragonese è invece quella di uno spettacolare acrobata sospeso sul filo di un’epoca dove tutto è vuoto, vertigine, insicurezza, spaventosa assenza di ogni fondamento: abissi ai quali reagire con i trucchi di un gioco di strategia.
Pochi mesi prima di morire, il grande romanziere, e pessimista, spagnolo Rafael Chirbes venne meno ai precetti dell’adorato Graciàn confessandomi che El Criticòn era il suo livre de chevet: “Perché racconta il mondo come se fosse un marchingegno sempre sul punto di andare in pezzi. Che non succeda, è cosa su cui riflettere e motivo di stupore”.
Marco Cicala